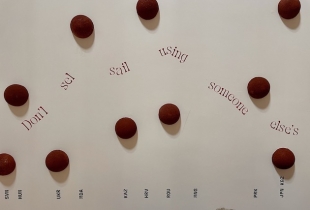» archivio blog
-
Basilea e oltre: temi primari tra arte, teatro, design e collezioni
data: 17-06-2015
-
Intervista a Nicola Toffolini
Inventore di mondidata: 24-04-2011
-
Donne senza uomini.
Installazione multimediale di Shirin Neshatdata: 01-03-2011
Biennale Architettura 2025: riuso, restauro e progettazione vegetale per rifondare il mercato
Architettura, scienza, agricoltura e innovazione unite contro il cambiamento climatico
L’economia della banana è un mondo - eco-circolare, imprenditoriale, costruttivo - che atterra alla Mostra di Architettura della Biennale di Venezia come quello della canapa, che in Italia in questo momento vive forse la più aberrante ed immotivata, soprattutto in piena emergenza climatica, delle stagioni proibizioniste nostrane.
Sono in ottima compagnia insieme a sistemi di recupero e riutilizzo di architetture vernacolari, scarti, suolo, tradizioni etnografiche e molto di più, incluso i sistemi di innovazione nella comunicazione di massa con cui il potere perpetra sé stesso che ha valso un premio (Leone d’Argento) alla timeline più ambiziosa ed unica in questo genere (Calculating Empires: A Genealogy of Technology and Power Since 1500) di Kate Crawford e Vladan Joler.
Potrei restare fino a notte fonda a dirvi cosa e quanto altro è fondamentale da essere conosciuto, esperito, studiato e laddove il contesto lo permetta, messo in pratica: sono oltre 750 i partecipanti. Spiccano figure che di solito a Venezia non sono invitate ma il curatore aveva premesso la natura di questa esibizione sin dai primi mesi di lavoro. Intelligens. Naturale. Artificiale. Collettiva secondo le intenzioni dell’ingegnere ed architetto Carlo Ratti - visto instancabilmente in giro ovunque durante la vernice, accompagnato da uno dei massimi dirigenti della Biennale - coinvolge figure che dovrebbero lavorare insieme data la complessità dei cambiamenti non solo climatici del pianeta e della statura contemporanea del costruttore come del committente. Accanto agli architetti, ogni progetto è composto da scienziati, ingegneri, data expert, biologi, agricoltori, attivisti, ONG di cittadinanza attiva.
Canicola, il padiglione del Bahrain Leone d’Oro di questa edizione, esemplifica che relazione con lo spazio ed il clima possiamo mettere in piedi con gesti semplici e radicati in ciascuno dei nostri DNA costruttivi; il riuso ed il restauro creativo in architettura sono anche il soggetto di un ottimo padiglione Danese e potrebbero fare la differenza, soprattutto in contesti storici.
La Gran Bretagna (del pari menzionata speciale dalla giuria diretta da Hans Ulrich Obrist) con Geology of Britannic Repair perde un’occasione e sembra più fare greenwashing della sua posizione coloniale in rapporto alla ricostruzione di Gaza, parte principale del bel layout espositivo molto fine, a mio avviso, solo a dare lustro alla appannata grandeur dell’isola-stato.
Il Kosovo e l’Irlanda sono gli unici padiglioni nazionali a parlare di relazione e di comunità con umiltà, dedizione e con idee innovative (nelle sale del Kosovo merita il viaggio la visita, guidata da uno dei loro ottimi mediatori, ad un progetto di biblioteca olfattiva create per cristallizzare i ricordi ed i saperi degli agricoltori alle prese con lo sconvolgimento climatico). L’Olanda costruisce un bar dello sport che inneggia alla diversità e funge, trasversalmente, da meeting point.
Il Belgio con Building Biospheres è e sarà nel pantheon dei miei personali Leoni d’Oro ed è l’esempio più elaborato dal punto di vista delle teorie di raffrescamento domestico ed urbano, variamente presenti in tanti progetti della mostra internazionale di Ratti così come in altri padiglioni nazionali (spicca quello tedesco: il primo luogo culturale a Venezia ad aver ottenuto di installare pannelli solari permanenti purtroppo ancora vietati in tutto il centro storico nonostante siano ormai in edilizia libera in tutto il paese dal decreto Draghi del 2021).
Curato dal paesaggista Bas Smets e dal pensatore e biologo Stefano Mancuso, è un gigantesco progetto di ricerca annuale in cui architetti, designer, paesaggisti e botanici, ingegneri dei dati, climatologi e altri esperti (insieme a Gand, politecnico capofila), si affiancano per sei mesi per utilizzare l’intelligenza naturale delle piante. E’ stata creata una gigantesca serra dove alcune specie selezionate (per specifici habitat) sono state messe a dimora per studiarne il comportamento estivo quando prima, nei sei mesi precedenti la Biennale, se ne è studiato il comportamento invernale: la traspirazione delle piante è un efficace controllo climatico e distribuisce frescura (abolendo il condizionatore d’aria che da solo è responsabile del 10% delle emissioni globali di C02 e dell’inquinamento diffuso). L’idea non è nuova, ad essere rivoluzionario è l’approccio messo a punto da Bas e Stefano per gli output desiderati. Una sezione del padiglione si concentra anche su alcuni materiali plant-based che vengono in aiuto per sfruttare virtù ‘laterali’ dalle azioni di raffreddamento, come ad esempio immagazzinare la preziosa umidità in eccesso con pareti di canapa e calce che la distribuiscono uniformemente nell’ambiente senza accumuli inutili quanto dannosi.
Torniamo quindi alle banane e alla canapa con cui abbiamo esordito e che abbiamo abbandonato in questa lunga perifrasi: insieme a funghi, fanghi o terre crude, mattoni di letame e molto altro fanno parte di un caleidoscopio di gesti costruttivi non di flaneur ma di intere popolazioni che nei secoli hanno adattato lo scarto o il sovrannumero a materie prima totalizzanti prima ancora che si parlasse di penuria, economia circolare e leggi green&blue.
I banani sono piante che fioriscono una volta sola e che producono tantissimo scarto che fino a poco tempo fa non era valorizzato ed oggi, complice anche certa alta moda, è diventato materialo ricercati. ‘Se il gesto dell’alta moda di assorbire un po’ di fibra non risolve il problema, è però un flagship incontrovertibile’ affermano Zhicheng Xu e Kevin Mastro che in Biennale tracciano una complessa sfida: 5.6 milioni di ettari nel sud globale, spesso monocolture imposte da cattiva colonizzazione, piantati a banane significano circa 115 milioni di tonnellate di rifiuto agricolo per anno, cosa fare quindi? Innanzitutto una risorsa per costruire.
Il banano non ha le proprietà termiche ed ignifughe della canapa (altra pianta che in natura produce molto prezioso scarto di cui non si butta via nulla come per il maiale) ma la sua fibra è adatta per il tessile come per l’isolamento e molto altro da scoprire nel padiglione circolare che i due architetti hanno costruito con legno da riforestazione certificata veneto e fibra di banana. Quel padiglione è anche simbolo di empowerment di intere comunità che possono affrancarsi dalla monocoltura agricola per aprirsi ad altri business che consentono a tutte le parti dei residenti di avere una vita non solo dignitosa ma da protagonisti del proprio avvenire.
Un gruppo di facilitatrici di public-advocacy e civic engagement brasiliane (Humanitas360) hanno invece esposto un progetto formativo ed informativo sulla canapa e sui mille utilizzi di questa pianta millenaria.
Utilizzata fin dall’antichità per produrre corde, vele e carta, la canapa sta tornando in auge nel XXI secolo come simbolo di innovazione sostenibile e il Brasile ha da poco reintrodotto l’utilizzo delle sementi di canapa industriale e anche la cannabis terapeutica fondando un consiglio governativo (Council for Social and Sustainable Economic Development, anche noto come Presidential Council o Conselhão) per stimolare il mercato della canapa in cui siede proprio la presidente di Humanitas360, l’avvocatessa Patrícia Villela Marino.
A Venezia Humanitas360 porta i frutti del lavoro di ricercatori e ong che Humanitas360 ospita nel suo hub CIVI-CO (alcune di queste associazioni danno lavoro a donne detenute o altri gruppi di cittadini marginalizzati), il cui posto d’onore spetta all’hempcrete, un calcestruzzo realizzato con fibre di canapa, che offre vantaggi unici per l’edilizia civile: leggerezza, isolamento termico e acustico, resistenza all’umidità. Soprattutto, la canapa è una pianta a crescita rapida in grado di catturare grandi quantità di CO₂ durante la sua coltura oltre che, come dimostrato anche in alcuni terreni attorno all’ILVA di Taranto dove prima dell’oscurantismo si produceva ricerca, pulire i terreni dagli inquinanti pesanti. Ancestral Innovation (l’installazione video presentata alla fine delle Corderie) invita il pubblico a esplorare gli usi e le applicazioni della canapa nella storia, mettendo in relazione la saggezza ancestrale con il pensiero architettonico moderno.
Chissà che Salvini possa nelle sue passeggiate a favore di flash incappare in questo progetto e ripensare la sua crociata contro la canapa industriale? Nessuna speranza, il suo comportamento è antistorico ed ideologico nella migliore delle ipotesi oltre che configgere con la libertà di impresa sancita da una legge nazionale (la 242/2016). Nella peggiore il vice-premier sta facendo un favore ai poteri forti e non al pianeta e chi lo abita. Non parliamo di n’drangheta calabrese, regione dove il vice-premier milanese fece man bassa di voti, o di mafia siciliana o di camorra campana. In Italia abbiamo la lobby del calcestruzzo, dei pannelli isolanti derivati da idrocarburi oltre che la lobby per eccellenza, quella farmaceutica. A proposito di isolamenti degli edifici (i cosiddetti cappotti termici che in Italia, in barba all’economia circolare, il governo giallo-verde impose di realizzare in materiali plastici), oltre a tanti esempi di realizzazioni in canapa che questa biennale ospita, il padiglione dell’Estonia - una delle repubbliche baltiche dove si concentra una grande tradizione di foreste sostenibili e industrie del legname - ubicato in Riva degli Schiavoni, ‘incappotta’ un edificio storico con il tipico sistema sostenibile e riciclabile in pannelli di legno tanto utilizzato nei secoli fino ad oggi dal popolo estone.
La canapa è protagonista anche del progetto presentato da Circular Engineering for Architecture (del politecnico ETH di Zurigo), Digital Structures Group, MIT Morningside Academy for Design, Ankuin intitolato VAMO, un catalizzatore per mostrare i molteplici cicli di vita dei materiali naturali. Una rete in tensione realizzata con corda di canapa e cerchi di legno riciclato vengono intrecciati per creare una struttura flessibile a forma di campana rivestita di materiali bio-based. Gli scarti vegetali, animali, minerali e altri materiali post-consumo che compongono il rivestimento sono stati trasformati in materiali architettonici riconoscibili. VAMO è una struttura leggera e trasportabile che verrà trasferita in Svizzera dopo la Mostra.
Ci sono tanti progetti di lunga durata in questa mostra, come le pratiche vernacolari protagoniste delle stazioni climatiche sul delta dell’Ebro in Catalogna nella mostra principale o quelli selezionati all’interno del padiglione spagnolo (Internalities racconta che ‘la natura non produce esternalità, non produce rifiuto ma solo internalità o flussi che vengono riassorbiti dai processi naturali stessi’). O come Ingesting Architecture, un film di Sumayya Vally e Counterspace concepito durante il lockdown che fa il punto sulle miniere di Johannesburg prendendo in esame il cammino della polvere delle miniere, strumento di apartheid che fa eco anche all’occupazione in corso in Palestina, per smantellare il corpo nero e la mente nera. Per coprirla e ‘imbiancarla’.
A vincere il Leone d’Oro è, tra l’altro, un progetto di lunga durata, concepito nel 2008 con un team leggermente diverso da quello che lo ha portato nel 2025 in Biennale: Canal Cafè firmato dallo studio Diller Scofidio + Renfro (la firm statunitense che firma anche il padiglione del VAC), la società statunitense di water management Natural Systems Utilities, SODAI, lo storico dell’architettura ed ex curatore della Biennale Architettura Aaron Betsky, lo chef italiano Davide Oldani. Si trova poco prima delle Gaggiandre: una serie di cilindri depurano con ioni e con fitodepurazione l’acqua del bacino dell’Arsenale per fare il caffè. Durante la nostra visita non è stato ancora possibile erogare la bevanda che ha reso l’Italia celebre nel mondo perché la ASL veneta doveva ancora completare l’iter di esame dell’output ma confidiamo che nei prossimi mesi si potrà bere. Elisabeth Diller ha portato il progetto avanti in tutti questi anni anche dopo la morte del marito Charles Renfro ed ora ha vinto l’ambito massimo premio riservato alla più brillante partecipazione alla mostra principale.
Accanto al Canal Café è possibile ammirare Song of the Cricket un intenso progetto della University of Melbourne: isole modulari flottanti che riproducono gli habitat naturali di insetti estinti per ripopolare la biosfera e reintrodurre la diversità perduta. Queste isole flottanti sono dedicate a una specie di grillo (di cui si sente il magico suono) che una volta popolava la laguna veneta ed è stato dichiarato estinto nel 1992.
Tutta questa Biennale è anche un inno all’altra America che inneggia alla diversità e alla difesa del pianeta (dove peraltro Ratti lavora dirigendo il Sensible Lab del MIT), quella delle grandi università e delle tante menti che emigrate in questo paese ne hanno fatto il primo in tanti settori della ricerca, da ultimo anche della robotica e dell’Intelligenza Artificiale (con cui tutte le schede dei progetti in mostra sono riassunte). Dove da anni lavora anche Paola Antonelli, membro della giuria e protagonista del design.
Proprio mentre i giornalisti hanno attraversato i padiglioni per recensire la affollatissima mostra, si sono diffuse le nuove regole che Trump ha assegnato ai futuri partecipanti del padiglione USA, che non abbiamo per scelta visitato (Israele è chiuso, così come il Venezuela e la Cecoslovacchia, quello russo è utilizzato dalla Biennale per gli incontri Educational, il padiglione centrale è in restauro).
Sarà vietato per ogni futura esibizione americana in Laguna da oggi in avanti parlare di inclusione, temi di gender e molto altro. Pena la cancellazione dei fondi della partecipazione e altre sanzioni previste per chiunque parli di DEI (Diversity, Equity, and Inclusion).
Come fanno notare i brillanti redattori di Hyperallergic, l’art journal di Brooklyn che ha da poco compiuto 15 anni e che da sempre è l’alfiere delle posizioni scomode nell’art world più importante del mondo, oltre all’obbligo di sottostare all’ordine esecutivo federale di Trump che bandisce discorsi su DEI, artisti e architetti americani che da oggi in avanti applicheranno per essere i protagonisti del padiglione americano alle Biennali di Venezia (l’unico ad essere di proprietà di uno stato, ancorché amministrato dalla Fondazione Guggenheim) devono evitare di dare fondi all’UNRWA che come sapete Trump ha bandito. Hyperallergic ha quindi fatto una ricerca e ha scoperto che, nella lunghissima storia di questa manifestazione unica al mondo e di tutte le partecipazioni americane sia alla Biennale Architettura sia alla Biennale Arte, nessun partecipante americano ha mai dedicato sezioni di mostre o elargito fondi a questa agenzia Onu o ai suoi membri presenti o passati. La rivista si chiede come mai questo esplicita avvertenza su UNRWA associata al bando per la Biennale.
Nel nostro paese dove in queste ore accadono incredibili ed incresciosi episodi di limitazione di libertà personali operati da forze dell’Ordine non sappiamo se su mandato diretto o indiretto del Governo, ci auguriamo di poter continuare a parlare di inclusione, diversità, biodiversità e, soprattutto, verità. E di restare una nazione democratica in cui vi sia separazione di poteri, rispetto degli articoli fondamentali della Costituzione e di tutti gli altri.
#carloratti
#SensibleLab
#MITBoston
#VeniceArchitectureBiennale
#BiennaleArchitettura2025
#Intelligens
#BiennaleArchitetturadiVenezia
#Calculating Empires:AGenealogyofTechnologyandPowerSince1500
#SumayyaVally
#Counterspace
#DillerScofidio+Renfro
#CanalCafé
#SongoftheCricket
#UniversityofMelbourne
#Hyperallergic
#USPavilion
#UNRWA